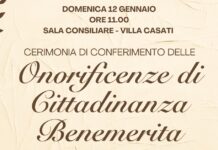‘Venite, signori e signore! Lo spettacolo sta per iniziare. Niente trucchi, non ci sono inganni. Dietro quella tenda una ragazza in carne e ossa si trasformerà davanti ai vostri occhi in un gorilla di oltre duecento chili. Forza, entrate! Occasione unica. Avanti, avanti. Ultimo spettacolo!’
Non aveva potuto ignorare quel richiamo, talmente disonesto e grossolano da diventare irresistibile. Nella penombra trovò solo un piccolo palco con un telo di velluto verde e due palme di plastica. Alla sua destra c’erano due uomini di mezza età, probabilmente entrati con la speranza di assistere a uno spettacolo erotico inusuale. Di fronte aveva una famiglia con madre, padre, due figli ancora piccoli. Tutti obesi, tutti e quattro con gli stessi occhi ravvicinati e le stesse gambe a salsicciotto piantate a X sulla terra come a dire io da qui non mi muovo.
Le luci si abbassarono. Infine, con un gran balzo sul palcoscenico, fece la sua apparizione la donna gorilla. Era semi-nuda e aveva iniziato a dimenarsi senza nessuna grazia in qualcosa che voleva imitare una danza africana. Di tanto in tanto la ragazza spariva nell’ombra battendosi i pugni sul petto poi, mentre i tamburi battevano un ritmo ossessivo, si infilava in fretta e furia una pelliccia più folta, una parrucca più ispida e una maschera di gomma che sembrava uscita da un libro di scienze naturali. La musica scricchiolava sgradevolmente. Il disco si incantò due volte.
Lo spettacolo era terminato con un’esclamazione di noia e un applauso a mani molli. Uscirono tutti, ma lei era rimasta dietro. Fissava il palco vuoto incapace di muoversi, ipnotizzata da tanto squallore. Tornò a casa in silenzio.
Quella notte sognò Santa Agnese con i seni tagliati, poi la sua amica Marina che rideva sguaiatamente e, per ultimo, un uomo nudo che camminava per la strada in evidente stato di erezione. Nessuno che dicesse niente, nessuno che fosse scandalizzato o che coprisse per decenza gli occhi ai bambini.
Si svegliò stanchissima. Suo marito dormiva al suo fianco. Respirava profondamente, con la pancia che si alzava e si abbassava dentro la canottiera traforata. Dove vent’anni prima c’erano stati capelli folti e ricci, ora splendeva un cranio rosa coperto di gocce di sudore. Lei cercò di ricordare l’ultima volta che avevano fatto l’amore, ma non ne fu capace. Si infilò sotto la doccia e scacciò anche l’ultimo pensiero di quel sogno indecente.
Poco dopo uscì per andare al supermercato. Fu là che lo incontrò. Successe esattamente all’angolo fra i surgelati e i cibi per i cani. A lei caddero di mano il gelato alla vaniglia, tre scatole di piselli, il pesce congelato. A lui sei scatole di Chump, giusto giusto sui suoi piedi. Successe come nei film made in Hollywood, di quelli peggiori trasmessi in TV di prima mattina. Si fissarono, si scusarono reciprocamente, si inginocchiarono in perfetta sincronia con un crac spaventoso delle teste. Si misero a ridere e quando lui parlò, quando lui le parlò lei si sentì tutta molle. Tutta molle e la testa leggera.
Era alto, magro e con i capelli brizzolati. La fissava con occhi tutt’altro che onesti e lei sentì che la felicità era lì, sospesa a mezz’aria, e non le importò del marito, né dei figli tiranni o del sicuro castigo di Dio. L’unica cosa di cui si pentì fu di non aver scelto per quella mattina un vestito un po’ attillato che le segnasse la vita, punto incantevole che sapeva di possedere ancora nonostante i chili di troppo. Ma comunque sembrava piacergli anche così: quarantenne soprappeso, senza ombra di trucco e con i tacchi bassi. E prima pensò che no, di certo si sbagliava, e figurati se un tipo del genere poteva avere pensieri del genere per una donna come lei: sbiadita, rotonda, con un elastico nei capelli e quel vestito comprato nei saldi alla Oviesse. Ma quando lui le chiese se le andava di bere qualcosa, lei annuì d’istinto e senza abbassare gli occhi. Lo seguì come si segue il destino quando ti cade ai piedi in quella strana maniera, senza preavviso, senza nessuna decenza.
Dopo pochi minuti erano seduti in un bar. Lui parlava e parlava:
“Se il Chinotto fosse lanciato con una campagna di prim’ordine, sfruttando al meglio i media, su scala internazionale, intendo. Sono certo che nel giro di due anni sarebbe un prodotto in competizione con la Coca-cola e la Pepsi. Quel che manca è il lancio commerciale, gli sponsor, gli investimenti necessari e l’immagine. Ecco: quella, soprattutto. È solo una questione di immagine. Se si proietta l’immagine giusta…”
Non riusciva a seguirlo. Non pensava affatto alla campagna pubblicitaria del Chinotto. Lei pensava a quanto fosse bella la sua bocca, a come lui muovesse con leggerezza quelle mani così curate, così eleganti. E sì, diciamolo pure: pensava anche alla cosa magnifica che lui doveva averci fra le gambe. Arrossì. Proprio lei, avere certi pensieri. Lei che non aveva mai tradito il marito. E adesso se ne stava lì, a immaginare come fosse il pene di un perfetto sconosciuto, che cosa lui le avrebbe fatto se fossero stati chiusi in una stanza con un po’ d’acqua, dei viveri, un letto. Cosa peggiore, pensava a cosa gli avrebbe fatto lei. Lei che intanto si lasciava accarezzare le mani, e ascoltava con piccoli brividi di piacere le parole che quell’uomo le sussurrava tormentandole il lobo dell’orecchio. La vita va vissuta pienamente – le diceva – senza paure, senza fuggire le occasioni magiche che ci sfiorano solo poche, pochissime volte nel corso dell’esistenza. Non ce n’era comunque bisogno. Lei non voleva affatto andarsene. Voleva lasciarsi andare, dimenticarsi di tutto. Quasi senza accorgersene si tolse l’elastico dai capelli e portò la mano di lui fra la massa lucida e nera che le cadde sulle spalle. Chiuse gli occhi, concentrandosi sulle dita che le accarezzavano la nuca e quella voce… quella voce che le ripeteva quanto fosse bella, quanto avrebbe voluto tenerla vicina, farle l’amore.
Lei sentì che l’uomo prendeva il suo viso fra le mani. La baciò. Un bacio profanatore che poco aveva a che fare con le telenovelas e i film Hollywoodiani con il bollino verde. E quando lui le disse: ‘andiamo’ lei lo seguì. Semplicemente.
La porta dell’hotel si chiuse dietro di loro con un piccolo rumore. Lui si avvicinò, le sbottonò il vestito di mussola, le palpò il sedere.
“Bella figa che sei. Vieni qui che ti lecco tutta…”
La frase la colpì come uno schiaffone.
“Per favore, non parlarmi così.”
“Così come?”
“Usando quei… quei termini.”
“Ma dai! Preferisci se ti do della racchia?”
Rise e intanto le sfilò il vestito.
Sperò che lui la tenesse vicina, che l’accarezzasse a lungo, prima. Ma lui l’abbracciò di sfuggita solo per sganciarle il reggiseno. Continuò a parlare senza freni. Era eccitante, disse. La osservò da vicino e in tutte le angolazioni. Le chiese di mettersi a carponi. Le ordinò si spostarsi in questa e quella posizione, di aprire di più le gambe, di alzare le ginocchia, appoggiarsi sui gomiti.
Si sentì profanata, conscia dei suoi chili di troppo, di quegli occhi che la scrutavano, che entravano in ogni sua imperfezione, in ogni piega del corpo.
Un attimo di assoluta lucidità. Qualcosa di amaro le si lacerò dentro. Il salto del puma. Lo scatto dei reni. Un respiro trattenuto a lungo fra la pelle sudata e il suo cuore. L’imposta che cigola. Il rumore di un taglia erba. Un bagliore. Là, dove la luce mastica la carne e l’odore di minestra si attacca alle lenzuola. Gli occhi sul riflesso dello specchio e la certezza che è tutto vero. Tutto vero. Chiuso e doloroso come il niente.
Chiuse gli occhi. Se ne andò lontano. Lasciò solo il corpo sul letto. Le mascelle contratte. Le gambe aperte.
“Sei un po’ inibita, eh? Non è che mi aiuti molto.”
Ridacchiò, e glielo mise in bocca.
Lei si sentì sporca. Stupida e sporca. Voleva solo andarsene, tornare a casa il prima possibile. L’uomo le mise una mano fra le cosce e lei sentì che là, fra le gambe, non c’era che plastica. Solo un triangolo di plastica senza vita, come le bambole con cui lei giocava da bambina. Voleva solo che finisse, ma lui si prese il suo piacere senza fretta, girandola e rigirandola più volte. Le fece alzare le gambe, inarcare la schiena, le chiese di affondare le unghie nelle natiche.
Se solo non fosse corso a lavarsi nel bagno venti secondi dopo essere venuto. Se solo lui l’avesse abbracciata, almeno dopo, e le avesse baciato la fronte.
Poco dopo la riportava al parcheggio del supermercato. In macchina era nervoso. Fumava. Le rivolse solo qualche frase banale, tanto per rompere il silenzio. Lei rispose a monosillabi.
La scaricò di fretta dandole un biglietto di visita e dicendole di chiamarlo se ogni tanto le andava di fare del buon sesso. Lei non rispose. Evitò il suo sguardo, prese il biglietto e scese.
Voleva solo correre via, ma si sforzò di camminare piano, con fare normale. Raggiunse la sua utilitaria. Aprì. Si sedette alla guida con movimenti composti.
Dallo specchietto retrovisore lo vide ingranare la marcia, sterzare con un cigolio nervoso delle gomme, sparire dietro l’angolo. Solo allora accese il motore.
Guidò in silenzio verso la città. I poster della superstrada erano pieni di visi sorridenti, di gente bella e felice. Sembravano prenderla in giro.
Imboccò il lungomare. Non c’era vento. Il cielo biancastro si confondeva con la lunga distesa di sabbia. Un mondo informe immerso in un’afa lucente e senza confini. Gli ombrelloni sotto il sole erano immobili. La spiaggia brulicava di corpi perfetti.
Si trovò imbottigliata in una lunga fila di TIR. Guardò più volte l’orologio.
Ferma al semaforo si trovò accanto un camion. Era dipinto con palme, alberi tropicali, pappagalli dai colori sgargianti contro un tramonto di fuoco. Avvinghiata ad una liana c’era l’immagine una donna provocante: i seni scoperti, solo un lembo di pelle di leopardo intorno ai fianchi. Accanto a lei la faccia spaventosa di un gorilla dai denti aguzzi, gli occhi iniettati di sangue e i pugni alzati verso il cielo
Guardò nella cabina di guida. Vide una donna minuta, senza ombra di trucco. Aveva i capelli raccolti, indossava una maglietta a righe e fumava con l’aria annoiata. No, non poteva essere lei – pensò. Questa ragazza era così dolce, così…. così normale.
I loro occhi si incrociarono per un attimo, poi scattò il verde. Lei guardò per l’ultima volta il viso della biondina, la sua aria slavata di ragazza di provincia. Inserì la prima. Accelerò.
Di colpo sentì un nodo allo stomaco, gli occhi riempirsi di lacrime. Dalla sua bocca uscì un lamento monocorde e lunghissimo. Scoppiò a piangere, con singhiozzi violenti che la scossero tutta. Dovette accostare.
Lasciò che il corpo si lasciasse andare a quel pianto: il viso sul volante, le mani che stringevano il cerchio di plastica. Rimase in quella posizione a lungo. Poi sentì qualcuno che batteva sul finestrino, piano piano:
“Signora, scusi… si sente male?”
A parlarle era stato un vecchio signore. Lei lo fissò con gli occhi gonfi. Era sudata, rossa in viso, il naso le gocciolava.
“No, no… sto bene…”
“È sicura? Se ha bisogno di qualcosa…”
“No, grazie. Non ho bisogno di niente. Adesso passa…”
Tirò su col naso e cercò di ricomporsi. Sperava che quel vecchio se ne andasse, che la lasciasse in pace, ma lui non si mosse. La fissava serio. Dopo un po’ aggiunse:
“Scusi se mi intrometto, ma mi dia retta. Qualsiasi cosa sia non ne vale la pena, mi creda. Se non si tratta di problemi di salute… tutto il resto si risolve. Finché abbiamo la vita… i soldi e tutti gli altri affanni, guardi, quelli si sistemano. Scusi se mi sono permesso… ma sa? Ho una figlia della sua età e vederla piangere così…. Tenga…”
Le allungò un fazzoletto. Era di cotone e a quadri. Era stirato e profumava di ammorbidente.
“No, guardi. Non saprei come restituirglielo.” – gli disse.
“Ma che dice? Non c’è mica bisogno di restituirlo. Da brava, tenga. Ah, se solo avessi la sua età, altro che piangere.”
Le sorrise. Lei gli fu grata per il silenzio che seguì, per non chiederle altro, per quel suo salutarla con un piccolo gesto del mento. Il vecchio le disse solo “mi raccomando”, poi riprese la sua passeggiata. Se ne andò a piccoli passi, un po’ curvo sotto il sole.
Restò a guardarlo fino a che sparì dietro l’angolo. Tirò su col naso, quindi accese di nuovo il motore.
Riprese il cammino verso casa. Erano le sei. Il sole era più basso e si cominciava a respirare. Passò davanti al Luna Park: stavano finendo di smontare. Non rimanevano che lo stand dei torroni e dello zucchero filato, un camion solitario, le gambe metalliche di una giostra abbandonate sul prato. Qualche cartaccia svolazzava sul terreno secco, calpestato, senza più un filo d’erba.