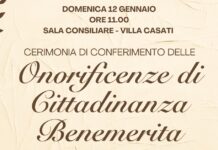Pamela era tonda e rossa, perciò tutti la chiamavano Mela. Era anche dolce come un frutto, ma questo non lo sapeva nessuno. Suo padre aveva un’amante – questo, però, lo sapevano tutti. L’aveva conosciuta un’estate di qualche anno prima, e le aveva ammiccato proprio sotto lo sguardo della moglie. L’amante era la loro vicina d’ombrellone, e Pamela all’inizio non aveva capito. Aveva solo dodici anni, Pamela, e quella donna le pareva una sirena, con le labbra violette e le gambe lunghissime.
Quell’estate ligure Pamela la ricorderà sempre perché sulla spiaggia, mentre la sirena e suo padre si scambiavano sguardi, dagli occhi della madre fuggì qualcosa. Qualcosa le scivolò via dallo sguardo, proprio così. Pamela per anni pensò che aveva perso la gioia che le teneva gli occhi allegri, ma poi capì che aveva smarrito se stessa, sua madre, aveva smarrito se stessa tra le scogliere, era franata negli abissi del mondo.
Quell’estate ligure Pamela la ricorderà sempre perché da quel momento sua madre prese a guardarla con occhi enormi, allucinati. Entrava con lei in bagno, si chiudeva la porta alle spalle e si spogliava completamente. Nuda, ripeteva forte: “Sei tu che mi hai fatto questo!” e le imponeva il desolante spettacolo del suo corpo pesante, sformato, grondante di grasso dal collo alle caviglie. I seni cadenti e grossi, le vene viola che laceravano il ventre, i fianchi duri e larghi, le gambe gonfie. Un corpo decadente, quello di sua madre, un corpo invecchiato presto, spaventoso e ripugnante. Pamela non voleva guardare: chiudeva gli occhi, cacciando via quell’immagine.
Mormorava piano: “Mamma, mamma…”, ma sua madre non c’era, non rispondeva, continuava ad urlare.
“Guardami! Smettila di frignare e guardami!”
Le comprimeva il piccolo volto nelle immense mani fino a quando la figlia non riapriva gli occhi e li piantava in quel molle paesaggio grigio e rosa. Pamela piangeva. Attraverso le lacrime quella massa che si ritrovava davanti era fluida, correva da tutte le parti: sembrava di essere in un acquario, davanti a un grosso pesce che presto l’avrebbe divorata.
Pamela se lo sognava la notte, quel corpo, appeso come i salami dal macellaio. Sognava quel corpo smembrato e agonizzante, grondante di sangue. Qualcuno gridava. Lontano si poteva scorgere sua madre scappare da quella carneficina, correre verso il mare; Pamela, però, non poteva muoversi: qualcuno le bloccava la testa e la obbligava a guardare il corpo maciullato.
Quando si svegliava era tutta un tremore e le pareva di sentire un tamburo suonarle veloce nel petto. Nascondendosi sotto le coperte pensava che se lei non fosse nata sua madre si sentirebbe ancora bella, e suo padre la guarderebbe come guardava la sirena sulla spiaggia di sole. Pensava che quel buio silenzioso e sospeso della sua stanza avrebbe forse potuto risucchiarla fuori dalla vita, e lo sperava davvero. La mattina, però, la luce tornava ad inondare la camera, e lei capiva che la notte non l’aveva trascinata via.
Così Pamela mangiava, mentre i sensi di colpa la divoravano e il corpo di sua madre la perseguitava. Aveva voglia di scomparire e mangiava. Si strafogava di cibo, Pamela, divorava qualsiasi cosa le capitasse davanti. Inghiottiva quantità strabilianti di dolciumi, soprattutto, e non poteva arrestarsi, non riusciva a frenare quelle mani fameliche. Parevano aver vita propria, le mani di Pamela, sembrava che in quella carne fosse imprigionato lo spirito di sua madre, che la obbligava a mangiare. Pamela non aveva fame, no, ma continuava a infilarsi cibo in bocca. Si vergognava di se stessa, del modo disgustoso in cui lo faceva. Osservava le briciole caderle sul petto, accumularsi tra le pieghe dei vestiti e precipitare sul pavimento; il succo zuccherato della frutta le colava sul mento, si appiccicava alle guance, le macchiava le magliette. Inorridiva al suono della pasta sminuzzata tra i denti, al rumore dei biscotti sbriciolati sulla lingua e a quello delle caramelle dure spezzate tra i molari. Ma soprattutto, la disgustava masticare la carne, passare la lingua sui denti e sentire che dei pezzetti erano rimasti intrappolati lì come prigionieri tra sbarre bianche: le venivano in mente i suoi sogni terribili, con la carne molle della madre appesa dal macellaio.
Odiava tutto questo, ma continuava a mangiare. Voleva così cacciare il dolore che aveva preso ad abitare quella casa; voleva che sua madre dimagrisse, che tutto quel grasso le scivolasse via dalle ossa. Voleva, soprattutto, inghiottire l’infelicità e la paura che la pervadevano e seppellirle in fondo allo stomaco, in quel buio abisso che era il corpo umano. Pensava che lì non l’avrebbero più assalita come bestie affamate – non si sarebbero più cibate, l’infelicità e la paura, della sua mente, dei suoi respiri.
Pensando di strappar via quel corpo rivoltante dall’anima di sua madre, Pamela mangiava, pronta ad assumere su di sé il peso dell’intero organismo che l’aveva data alla luce; pronta a fondere il proprio corpo col suo per liberarle entrambe di quel male, per accogliere la sofferenza materna nel proprio petto, per riuscire ad avere indietro la mamma, quella vera.
Poche volte, in quegli anni, Pamela vide lo sguardo della donna che l’aveva generata tornare luminoso. Quelle volte sua madre cucinava piatti meravigliosi, saporiti, pieni di odori buoni, e i suoi occhi non erano più allucinati, tornavano umidi e quieti. Alla mamma era sempre piaciuto cucinare; lo faceva con gioia: apriva le finestre e cantava, girando a piedi nudi sul pavimento della cucina, i capelli coperti da bandane azzurre. In quei momenti voleva essere sola, non si faceva aiutare da nessuno: diceva che quello era l’unico momento in cui poteva ritrovare la pace. Perciò Pamela, che non voleva disturbarla, si faceva piccola piccola e la sbirciava dallo stipite della porta. La osservava danzare sulle piastrelle pulite: le sembrava così leggera, come se quel suo corpo monumentale si librasse fino al soffitto.
Quelle volte Pamela credeva che tutto ciò che era successo fino ad allora fosse stato solo un altro dei suoi brutti sogni, pensava che sua mamma non era mai scivolata via sulla sabbia, strisciando fino in fondo al mare. Pamela sorrideva e ascoltava quel canto diffondersi in tutta la casa, ed era come addormentarsi in un tiepido sopore; come quando era bambina e, le mattine d’inverno, ancora immersa nel dormiveglia, si rannicchiava sotto le coperte mentre il caldo la avvolgeva. Allora la mamma le si sedeva accanto e cantava piano al suo orecchio, carezzandole i capelli, in modo che il suo risveglio fosse dolce, dolce e piacevole.
Quelle volte, mentre sua mamma cantava e cucinava piatti prelibati, Pamela sentiva dentro di sé qualcosa tremare e chiudeva gli occhi. Aveva paura di riaprirli: temeva di scoprire che sua mamma era scomparsa di nuovo, ché forse le finestre aperte avevano fatto volar via il suo spirito. Perciò la parte migliore era quella in cui abbassava le palpebre ed era come le mattine d’inverno, quando tutto andava lento e il mondo fuori mormorava piano una musica francese.
*
Col passare degli anni, invece, Pamela divenne Mela, tonda e rossa come un frutto. Il liceo era cominciato e già quasi finito e lei non era riuscita a salvare l’anima di sua madre, a strapparla via da quella caverna di tenebre che era il suo corpo sempre più pesante. Non era più riuscita nemmeno a guardarsi allo specchio, Pamela: le volte in cui aveva catturato la propria immagine in quel mondo impalpabile di vetro, infatti, non aveva sorpreso altro che il corpo di colei che l’aveva messa al mondo. Col passare degli anni Pamela divenne Mela, e Mela divenne sua madre.
Continuava a mangiare quanto prima, instancabilmente, anche se la verità è che Mela era esausta. Esausta di quel male che le si attorcigliava nella gola e che non riusciva ad estirpare, di quella fame insaziabile e nervosa, degli incubi; di sentirsi così: infinitamente antica, debole, sola. Mela era così esausta che aveva voglia di morire. Eppure non poteva smettere di far quello che seguitava a fare da anni, dalla mattina alla sera: mangiare. Perché, anche se odiava se stessa e il disgustoso modo che aveva di infilarsi il cibo in bocca, mangiare le dava un poco di conforto. L’alleviava, per pochi istanti, del peso che le gravava sul petto.
Mela, però, non mangiava cibo. Mandava giù palate di rimorsi, di terrore, d’insicurezze, di dolorosa solitudine. Quel groviglio amaro si presentava nella veste di paste, salumi e leccornie e si faceva spazio dentro il suo stomaco in maniera brutale. Così Mela non faceva altro che ingurgitare la parte più spaventosa e oscura di se stessa, fino a farla sedimentare nel corpo straniero in cui era intrappolata – il corpo di sua madre –. A volte voleva vomitare, buttare fuori se stessa da quella caverna mostruosa e lasciar correre via la piccola Pamela impaurita e tremante che ancora viveva in quel buio profondo.
Altre volte no, non aveva le forze per lottare coi demoni che abitavano con lei la grotta nera piena di echi e rimbombi. Questo accadeva di notte, quando non riusciva a dormire. Allora andava in cucina e si versava una grande tazza di latte; chiudeva gli occhi e cercava di bere tutto in un sorso solo, trattenendo il respiro. Sperava che il latte le entrasse nei polmoni e la facesse morire, sperava di annegare in quel freddo bianco per poi cadere a terra e non svegliarsi più. In qualche modo, però, Mela riusciva a finire il latte prima che le colasse giù nei polmoni. Ce la metteva tutta, in quelle notti, a morire. Ma Mela non moriva, perché quelle mani che non erano sue smettevano di premerle la tazza contro le labbra proprio nel momento in cui le mancava il fiato. Il latte le finiva in faccia, e allora il liquido fresco cadeva giù, sotto la camicia da notte, tra le pieghe del suo corpo tondo e pieno. Ed è così che Mela usava il latte, primissima e preziosa fonte di vita, per smettere di vivere.
Mela trovava l’assurdo meccanismo che la induceva a trangugiare cibo – dolore, sollievo, malessere – crudele e brutale, e la colpa era solo di quella donna ormai sconosciuta che viveva con lei. Mela odiava sua madre e la follia che le si agitava dentro, la odiava anche e soprattutto perché si era impossessata del suo corpo di bambina e l’aveva trasformato in una creatura mostruosa.
Eppure, quando sua madre cantava e preparava da mangiare per tre, apparecchiando la tavola per la famiglia del passato, perennemente dimentica del fatto che l’uomo che aveva amato l’avesse abbandonata, Mela mangiava anche la porzione destinata a suo padre. Lo faceva per farla felice, perché desiderava in maniera folle e disperata che sua madre l’abbracciasse, che tornasse quella di prima, che capisse quanto amore lei, sua figlia, così fedele, ancora le riservava.
“Dov’è?” chiedeva sua madre, smarrita, con occhi vacui.
“Stasera non c’è, lavora”.
“E quando torna?”
“Domani, mamma”.
“E il suo piatto? Come facciamo? Il suo piatto! Ho cucinato per lui! Il suo piatto!”
“Mangio io, mamma, non ti preoccupare, stai tranquilla”.
A quelle parole, sua madre si calmava. Si sedeva e studiava Mela finire la sua porzione e quella del padre. Allora le sorrideva e diceva con affetto: “Come sei brava, bambina, come sei brava” e Mela, a sentirla, si commuoveva nel profondo.
Da parecchi mesi, ogni giorno, la medesima scena andava ripetendosi. Ogni sera sua madre preparava la cena per quel marito che tanto aveva adorato, e lo attendeva. Ogni sera dimenticava che non sarebbe mai arrivato, che l’aveva abbandonata. Ogni sera quella grossa donna che era sua madre diveniva fragile e mansueta come una bambina, e a Mela, diventata madre di sua madre, veniva da piangere. Così, pur detestandola, ogni sera mangiava per sé e per suo padre per farla felice, e le diceva che era un’ottima cuoca. Sua madre sorrideva guardando lontano – forse quel mare ligure di tante estati prima – e pareva davvero che mai alcun dolore avesse gravato sul suo cuore.
A Mela sembrava di elemosinare, ogni sera, un affetto che altrimenti non le sarebbe mai più stato concesso. Quel “Come sei brava, bambina, come sei brava” era l’unico vero nutrimento che la tenesse in vita, che le facesse scivolare addosso le ore nell’attesa del momento in cui il giorno sbiadiva nel cielo: il momento in cui sua mamma cantava davanti ai fornelli. Mela ingurgitava cibo di continuo, ma era convinta che, se ogni sera non avesse udito quelle parole, il suo stesso corpo le sarebbe crollato addosso, travolgendola con tutto il peso che a fatica sopportava.
*
Era l’ultimo anno di liceo. Mancava poco alle vacanze di Natale e le porte delle classi erano spalancate, tutti i ragazzi ridevano e parlavano a voce alta, correvano sulle scale e si scambiavano gli auguri.
Mela, invece, tremava tutta sola in mezzo al corridoio della scuola, ansimando forte. Corse nel bagno incespicando nei suoi stessi piedi, col cuore che batteva troppo in fretta – desiderava quelle mattine d’inverno, quando il mondo girava piano –. Le si annebbiò la vista, mentre i pensieri le vorticavano nella testa e lei non riusciva a fermarli. Ancora una volta, era priva di controllo sul suo stesso corpo: non riusciva a calmare quel violento tremore che la scuoteva dalle gambe alle mani – quelle mani che non erano mai state sue.
“Apri gli occhi, apri gli occhi e guardami”.
Qualcuno era entrato nel bagno con lei e si era chiuso la porta alle spalle, le aveva preso la testa tra le mani. Lei aveva cominciato a dimenarsi: pensava che fosse sua madre. Sua madre faceva proprio così, entrava nuda nel bagno e se lei chiudeva gli occhi la obbligava ad aprirli, la forzava a guardare.
“Respira, dai, apri gli occhi. Guardami, non aver paura…”
Era come una musica dolce, quella che le arrivava sul viso. Così dolce che avrebbe voluto addormentarsi, lasciarsi invadere dal tepore e dormire, solo dormire, finalmente dormire.
“Guardami, Pamela, forza!”
Nessuno, a scuola, la chiamava Pamela. Solo Mela. Aprì gli occhi e si accorse, imbarazzata, di essere stretta in un abbraccio caldo, stesa per metà sul pavimento. Lentamente smise di agitarsi e di tremare.
“Ti ho vista in corridoio, ho visto che non stavi bene, eri pallida e tremavi e allora…”
“Chi sei?”
“Sono Ismael, ma tu chiamami Mael… mi chiamano tutti Mael” mormorò la voce.
Pamela guardò il volto del ragazzo: aveva la pelle scura, lunghe ciglia nere, il sorriso un po’ storto di chi sorride poco. Si ricordò di Ismael: facevano spagnolo insieme da due anni; era molto alto e magrissimo, se ne stava sempre chino sul banco, parlava a voce bassa. Si rese conto di non averlo mai guardato bene. Non aveva mai fatto veramente attenzione a nessuno, a scuola, perché mai avrebbe sperato che qualcuno si accorgesse di lei. Così lei non si era accorta degli altri.
Ora lo guardava bene. Il suo viso le piaceva.
“Grazie, Mael”.
Pensò a quel nome: Mael. Le ricordava il miele. Lo sussurrò, assaporandone il suono sulle labbra. Dopo qualche istante di silenzio, Mela sorrise: si accorse che Mael era l’anagramma del suo nome.