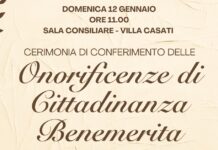In una camera del reparto terapia intensiva dell’ospedale centrale di Barcellona, egli giaceva sul suo letto vicino alla finestra. All’ultimo stadio di una cirrosi epatica, in coma da due giorni, Pablo Maria Sotèro stava morendo senza più dolore.
Da quando era stato ricoverato, una settimana prima, nessuno era mai andato a fargli visita. Non un parente né un amico. Gli infermieri ne erano rimasti dispiaciuti, e passando dalla sua stanza pensavano: pover’uomo, senza un cane che l’assista. Nessuno che si ricordi di lui. Che brutto modo di andarsene…
I più credenti fra loro si facevano di nascosto il segno della croce e pensavano: povero señor Sotèro, tutto solo nell’ora più difficile, senza il conforto di un amico. Ed erano stati con lui più premurosi e attenti, finché non aveva perso conoscenza.
Ma gli infermieri, in tutta la loro solerzia, non potevano certo accorgersi dell’invisibile folla che lentamente si stava raccogliendo intorno al capezzale di Pablo Maria Sotèro.
In quel mite pomeriggio barcellonese, al 110 de La Rambla, la Boquería, il più antico mercato cittadino, stava calando il sipario sul suo magnifico campionario di carni di toro e di ogni altra bestia, verdure e pesce di giornata, crostacei e frutti tropicali. Allestita in un edificio sorretto da colonne ioniche, la Boquería esponeva sul marmo dei suoi banchi tutta la materia prima della cucina locale.
Sui banchi del pesce i frutti di mare emanavano il secco profumo dell’acqua salata; gamberi di specie diverse formavano macchie di color rosso acceso, grigioverdi o arancione tenue; le granseole giacevano rovesciate come fragili pepite, le pericolose chele degli astici erano state fasciate col nastro adesivo per renderle inoffensive, mentre un bel giallo vivo brillava sulla fronte rotonda delle orate.
Le spezie e la frutta secca diffondevano nell’aria fragranze pungenti e offrivano allo sguardo una seducente gamma di colori. La carne di maiale, finemente lavorata in prelibati prosciutti, pendeva invitante sulla testa di chi, volendosi concedere un pasto «alla popolana», appoggiava i gomiti a un banco e ordinava un paio di tapas con un buon bicchiere di cava catalano.
Centinaia di candele votive accese a Sant’Eulalia, patrona della città, rischiaravano l’interno della Seu, l’imponente cattedrale a tre navate che dominava il Barrio Gotíco.
Fuori della cattedrale, tracce di mura romane affioravano qua e là nel labirinto di pietra grigia delle strade medievali, dove le botteghe antiquarie rigurgitavano stampe, mobili e libri antichi, complementi d’arredo in stile coloniale e un’impressionante scelta di armi d’epoca fra le quali pezzi di cui si certificava grottescamente che avessero ucciso «almeno un uomo». E questo accanto ai magnifici palazzi del XIV secolo e alle chiese gotiche di Sant Just e Santa Maria del Pi, sempre affollate di fedeli locali, così da formare quella speciale miscela di orrore, bellezza e paradosso, che spinge molti ad amare le grandi città del mondo e tanti altri a odiarle per le stesse ragioni.
Pablo Maria Sotèro non aveva mai pensato di poter vivere in un altro luogo che non fosse Barcellona. Per cinquant’anni aveva fatto musica suonando chitarra e armonica sulle Ramblas, offrendo melodia e parole alle milioni di persone che in ogni stagione gli erano passate davanti, talvolta tirando dritto, talvolta fermandosi ad ascoltare per poi gettare una moneta nella sacca della sua chitarra.
Di Barcellona, negli anni, aveva conosciuto e amato ogni angolo di strada; le case stravaganti e lo spettacolo permanente delle Ramblas, i riflessi metallici del sole sugli ombrelli e i ventagli della casa di Bruno Cuadros, in plaça de la Boquería, i gatti randagi che si contendevano i rifiuti del mercato; l’odore del porto, oleosa miscela di iodio e nafta, salsedine e acciaio, gli angoli morti delle banchine presidiati dai gabbiani, le feste popolari, il sudore, la forza e l’equilibrio dei castellers, decine di uomini, donne e bambini, che l’uno sulle spalle dell’altro formavano piramidi umane sorrette alla base da un impressionante intreccio di braccia; il boato del Camp Nou, che si propagava in tutta la città come l’eco di un tamburo, quando il Barça segnava un gol.
Pablo Sotèro non aveva votato la sua vita al lavoro né al guadagno, non all’amore coniugale né alla religione, mantenendo una distanza equa da tutto ciò che più frequentemente attrae l’animo umano e se ne appropria. Quanto al denaro, ne aveva fatto volentieri a meno, ogni volta che aveva potuto, barattando la sua musica con un buon pasto e un letto su cui crollare esausto, a fine serata, con la testa ancora ronzante di musica.
Così era stato ognuna delle infinite volte in cui aveva suonato fra i tavoli delle coctelerie o nelle piazze del Barrio Gotíco, sotto i portici di Placa Reial e nei locali del centro storico, per intrattenere le comitive di turisti fra un piatto di paella e una caraffa di sangria.
Della vita Sotèro amava tutto, avendola ridotta alla semplicità essenziale delle amicizie, del vino, del diverso sapore dei cibi, della gioia istintiva di suonare scaldandosi al sole o potersi riparare dalla pioggia davanti a una tazza di caffè fumante. Con l’armonica in bocca sdraiarsi sull’erba dei parchi cittadini d’estate, all’ombra delle piante, o guardare Barcellona dall’alto, fumando seduto sulla spettacolare ruota panoramica che dalla collina del Montjuic si affacciava sulla città.
Di sera, poi, perdersi con leggerezza nella strabiliante geografia dei ristoranti del Port Veil, dove la musica di Sotèro non si vendeva quasi mai per denaro, nossignore, ma per un piatto di riso brodoso fra i più buoni del Mediterraneo.
In quella parte di Barcellona che moriva sulle banchine del porto c’erano negozi di merluzzo salato, le bacallonerias, dove il pesce si dissalava ancora con l’acqua corrente dentro le vasche di marmo, mentre i ristoranti e le taverne diffondevano i profumi della cucina marinara catalana, che da sola riempiva il cuore di Sotèro e lo rallegrava.
Allora le note della sua chitarra salivano confondendosi col fumo delle grigliate di pesce freschissimo esaltate dal gusto dell’allioi, una salsa di aglio pestato montata con olio di oliva, o della salsa picata in cui l’aglio veniva mischiato a prezzemolo, mandorle e zafferano.
I temi delle sue canzoni diventavano quelli vibranti dell’indipendentismo catalano, quando il menù proponeva ricette tradizionali come lo xató, un’insalata di baccalà e tonno, acciughe, scarola e olive nere, o il baccallá a la llauna, prima passato in pastella e fritto in olio, quindi cotto al forno con salsa di pomodoro e vino, oppure la zarzuela de pescado: una zuppa di pesce profumata di essenze mediterranee, composta di vongole e aragosta, dentice, cernia e altre varietà di pesce di fondo.
Le ricette a base di crostacei e frutti di mare andavano gustate su una musica diversa. Bogavante*, cigalas*, almejas*… il ritmo cambiava e le note di Sotèro cadevano snocciolate una a una per accompagnare la lingua e i denti che scavavano nella cedevole corazza dei crostacei o frugavano nei gusci aspri di limone dei frutti di mare, in cerca delle polpe più saporite e nascoste. Di tanto in tanto smetteva di suonare e si sedeva a un tavolo qualsiasi, fra la gente, per gustare a dovere un piatto di arroz negre* o di chipirones fritos*, oppure un suquet de rape* con una buona bottiglia di vino bianco del Pendés.
Era quello il suo compenso, insieme alle offerte che i clienti lasciavano sul tavolo.
Seguitava a suonare e a cantare fino a notte fonda, finché c’era qualcuno disposto ad ascoltarlo e poi ancora, in strada, per gli amici e le prostitute, annullando quel confine fra il giorno e la notte che diviene superfluo se non hai nessuno che ti aspetti a casa né una casa in cui farti aspettare.
Gli capitava spesso, poco prima dell’alba, di trovarsi ancora con le gambe sotto il tavolino di uno di quei locali che non chiudono mai, davanti a un piatto di merluza al cava* o di pato con higos*, a spendere in cibo e in una profumata bottiglia di Riojas il ricavato di una serata di musica.
Anche se Sotèro non disdegnava affatto di suonare in quei locali dov’era chiamato a esibirsi, la sua musica più vera, libera e incondizionata, quella che scaturiva dalle profondità del suo animo e non trovava espressione che sotto il cielo azzurro delle Ramblas, era un’altra.
Nel suo vagare di notte per i quartieri di Barcellona aveva conosciuto il desolato candore delle prostitute, simili a rose sgualcite; aveva cercato a fondo negli occhi dei drogati per scorgervi quel barlume di rivelazione che l’eroina concedeva a coloro che lentamente stava uccidendo, e senza timori né preconcetti aveva avvicinato mendicanti, ladri, alcolizzati, folli, transessuali, poeti, omicidi: la vasta schiera degli animali notturni, refrattari al sole che gettava una luce sconveniente su sensibilità e drammi troppo accentuati per poterla sopportare. Per lunghe ore si era soffermato a parlare e a bere con loro, e per loro aveva suonato spesso fino alle luci dell’alba.
Da questo interesse innato per gli ultimi, gli emarginati, gli sconfitti, erano nati gli eroi delle sue canzoni. C’era l’anarchico Esteban, poeta cieco che nella soffitta di casa dava rifugio ai ricercati, e quando i poliziotti bussavano alla sua porta, da dietro gli occhiali neri rispondeva tranquillo, con volontaria ironia: “Non ho visto nessuno”.
C’era Ricardo il medico dei poveri, che per anni aveva esercitato la professione per amor del prossimo e della scienza, curando anche chi non aveva i soldi per pagargli le parcelle, finché, abbandonato dalla moglie, disprezzato dai figli, deriso dai colleghi, si era ritrovato nella stessa condizione dei suoi assistiti e anche adesso, vestito di stracci nella sala d’aspetto della stazione, con le mani nere di miseria e gli occhi miopi sempre attenti, non sbagliava una diagnosi.
Dalle canzoni che Sotèro interpretava sulle Ramblas affioravano le testimonianze di un’umanità offesa, ferita: di Carlos, precipitato dal ponte dove lavorava sospeso in aria per ore a saldare l’acciaio; di Jago e di Miguel, cinque figli in due, scaricatori di porto uccisi dal veleno di un container di scorie radioattive; di Gustavo «lo scemo del villaggio», morto disperato in manicomio dopo che per tutta la vita aveva cercato invano di comunicare col prossimo, nient’altro che questo, di farsi ascoltare, come ogni uomo necessita, da chi non aveva saputo riservargli che sarcasmo e commiserazione, povero idiota, bisbigliavano meschini, mentre era la persona più ricca di spirito che avessero mai incontrato.
Quando il dottore entrò nella stanza di Sotèro, erano già in tanti intorno a lui. Sembrava dovesse chiedere permesso, tale era l’assembramento di gente che circondava il letto. Invece entrò senza difficoltà, così come le due infermiere che lo accompagnavano.
Su una seggiola di metallo ai piedi del letto, sedeva tranquilla una giovane donna dal viso bello, corti capelli castano chiari, vestita leggera, gli occhi verdi e sereni. Sedeva tenendo le gambe unite, composte, e aveva entrambe le ginocchia escoriate.
Il dottore, che procedeva leggendo distrattamente la cartella clinica di Sotèro, parve intrampolare nelle gambe nude della ragazza. Passò invece attraverso di esse come se non gli fossero di alcun ostacolo: come se quelle gambe nude e segnate non avessero consistenza.
Di lei avevano parlato i giornali un paio d’anni prima, quando alla foce del Besòs, a est di Barcellona, era stato recuperato il corpo esanime di una giovane prostituta che qualcuno aveva strangolato e poi gettato nel fiume. Come estremo richiamo a una dolcezza che in vita le era stata negata, la corrente del fiume l’aveva avvolta e trascinata via, facendola danzare nel quieto incantesimo dei gorghi d’acqua, cullandola così fino alla foce.
Quando il dottore le passò davanti, lei non si scompose. Aveva inclinato il capo, scoprendo i lividi viola sul collo, e adesso osservava Sotèro con il volto pervaso da una sottile apprensione.
In piedi accanto al letto, un giovane soldato in mimetica assisteva alla scena con le braccia lungo i fianchi. In mezzo al petto la divisa era squarciata e imbrattata di sangue. Una macchia nera, densa come inchiostro, continuava ad allargarsi imbevendo il tessuto. Viscido sangue fresco macchiava le dita del ragazzo.
Aveva le guance lisce, larghi occhi lucidi e le ciglia lunghe, l’ossatura del viso appena pronunciata. Guardava preoccupato Sotèro, senza parlare, senza tradire nessun’altra emozione che una lieve tristezza. Non si curava nemmeno del sangue che aveva addosso. Era la morte a vent’anni, tragico emblema di tutte le guerre.
Chinato accanto a Sotèro c’era un tizio che gli parlava all’orecchio con fare da amico. Aveva in testa un cappello nero, i capelli un po’ lunghi, il collo e le mani abbronzati, le mani, soprattutto, che facevano contrasto col bianco del lenzuolo. Aveva appoggiato a terra il cartone del vino.
Era l’uomo di strada, il clochard, il mendicante senza fissa dimora, senza una famiglia a cui badare, senza nessuno da dover fregare ogni giorno per guadagnarsi il pane. Niente chiavi né telefono, nessun codice fiscale o tessera sanitaria. Quell’uomo era tutti i compagni che Sotèro aveva avuto e per i quali tante volte aveva suonato, condividendo con loro vino e pensieri sulle panchine di pietra fredda o al calore delle braci, nelle placide notti di luna piena come in quelle di pioggia e vento, confortati dal vino, dall’amicizia e da un inesprimibile senso di libertà.
La prostituta, il soldato, il mendicante. Così come tanti altri là intorno, tutti loro erano giunti da indefinibili distanze, riemersi dalle profondità dell’ignoto per raccogliersi al capezzale di Pablo Maria Sotèro e assisterlo in punto di morte perché non si sentisse solo.
Venivano da quel luogo che da millenni i vivi si affannano a chiamare paradiso, oppure inferno, o più semplicemente aldilà, e per esso disputano e arrivano a odiarsi, ma che forse non è che un’assenza di materia senza più dolore né affanni, nessun giudizio, nessuna beatitudine o condanna, né premi né castighi che andrebbero a turbare uno stato di quiete superiore, una presa di coscienza finale, assoluta e definitiva.
Quando il dottore e le infermiere furono usciti, loro invece non si mossero. Rimasero impassibili a vegliarlo, mentre Sotèro giaceva su un fianco e il suo respiro era tranquillo. Non c’erano in lui sofferenza né angoscia, piuttosto una sensazione di pace, di protezione. La stessa di un bambino che si è appena staccato dal seno materno e nel sonno assapora ancora la dolcezza del latte.
Sembrava dormisse, Sotèro. Semplicemente. Come chi è circondato da amici.
NOTE
Bogavante*, cigalas*, almejas* Astice, scampi, arselle
arroz negre* risotto al nero di seppia
chipirones fritos* calamari fritti
suquet de rape* coda di rospo
merluza al cava* merluzzo in salsa di spumante
pato con higos* anatra ai fichi