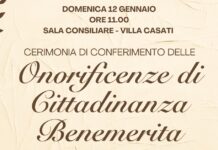1
Rovente l’estate parigina, giugno mille settecento ottantanove.
Il sole brasa le pareti e i tetti delle ville più alte, e l’acciottolio sconnesso delle vie è brace per gli incipriati parrucconi in ghingheri e bastone da passeggio.
Ribolle rumorosa, la Francia di fine secolo, simile a una zuppa sul fuoco. Borbotta un blub blub blub gemello al bla bla bla delle assemblee cittadine, e fuma un odore, povero ma giusto, come di roba da mangiare più che da gustare.
Il vento prende a braccetto quell’aroma e lo spande da rue de Chartres a rue de Chaligny e in ogni altra strada.
I cittadini lo annusano e ne seguono la scia. Sperano in un banchetto che li appaghi e li ripaghi di quanto speso per patire la fame. Si affrettano in folla per non perdere il posto in tavola.
Il pranzo sta per essere servito.
2
Intanto Philippe Lamont-Souvier cucina.
Impasta, mescola e soffrigge. Impiatta e guarnisce.
Lo fa con la raffinata perizia per cui è uno degli chef più giovani eppure celebri dell’intera Francia. Compone melodie con i mestoli nei tegami, dipinge le stoviglie con le forchette e scolpisce di grazia a suon di coltello anche la più anonima patata. Armonizza i sapori con la calibrata bilancia del proprio gusto ricercato.
Fra fornelli e pentole scintillanti, entro le sicure mura della reggia di Versailles, lo chef Philippe Lamont-Souvier, incurante dell’infuocata stagione parigina, cucina.
Immerge il mestolo nella zuppa poi lo porta alle labbra. Gonfia le pesche che ha per guance e soffia. Imbocca e assaggia. Schiocca la lingua, annuisce. E sorride.
– Un pranzo da re, – commenta.
E ritorna a cucinare.
Un pranzo da re per il Re.
3
Il sole investe il salone attraverso le ampie vetrate affacciate sul verde che avvolge la reggia di Versailles. Le posate d’argento brillano sulla tovaglia candida di bucato, stesa lungo una tavola che ben potrebbe ospitare una cinquantina di ospiti.
Sono solo due, però, i commensali, seduti ai capi opposti del desco, così compunti nel fragile belletto da parere due statue di gesso. Nemmeno gli stomaci brontolano, sebbene l’attesa sia ormai sconfinata nell’ora tarda del rifinimento.
Non è da nobili, del loro rango poi, lamentarsi, né col corpo né con le parole. E non per un galateo squisitamente di corte, ma perché altra è la natura del potere. Il potere ottiene sempre quel che vuole e quando desidera. Anche a dispetto delle apparenze.
Luigi XVI nega l’attesa correndo con lo sguardo, senza però muovere gli occhi, lungo gli arabeschi ricami della tovaglia.
Maria Antonietta sopisce l’imbarazzo dell’appetito con una carezza sul ventre, che il tavolo ben nasconde all’occhio del consorte.
Non aspettano, no. Regalmente affamati piegano il languore a un’attesa da loro imposta.
Poi, cristallina, una campanella suona. L’aroma caldo di spezie filtra da sotto la porta.
Sorridono, Re e Regina, e da sedie come troni concedono con autoritaria benevolenza il loro permesso.
«Potete servire, adesso»
4
– Bernadette, – le urla madame Vessai dall’altro lato del bancone, allungando un paio di scodelle fumanti. – Tavolo cinque. Due zuppe. Muoviti.
Bernadette serpeggia fra i tavoli con la grazia di un’equilibrista, nonostante rechi in grembo una pila storta di stoviglie sporche, alta per fortuna fino coprirle il rigoglioso seno quindicenne. Scavalca gli inciampi di gambe fuori posto, e schiva con colpi d’anca le grevi manifestazioni d’apprezzamento rivolte a lei, e più al suo sedere, dagli alticci avventori. In quanto alle richieste fra gli sghignazzi
– Bernadette, servimi la patatina.
– Bernadette, fammi vedere quanto è cruda la tua ostrichetta.
– Bernadette, l’ho io la crema giusta per il tuo bignè.
– Bernadette, ma cherie.
– Bernadette!
– Ah, Bernadette!
le scaccia arricciando le labbra in un broncio di cortese sufficienza.
Ordinaria amministrazione alla Taverne de pauvre voyageur de Madame Vessai.
Madame Vessai è un’ottima cuoca. Da borgata, certo, e per chi ha pochi spiccioli nelle braghe. Qualcuno s’ingozza con una zuppa di verdura e pane, opaca per le chiazze di grasso – quanto resta di un misero pollame – che allappa bene la bocca. Altri si appesantiscono con stufati di patate e cavolfiori, e qualche ritaglio di carne. Quartini di vino agro sono la prassi per buttar giù il groppo del cibo e della vita. E dimenticare. Forse fuggire.
Ma nessuno può.
Nessuno.
Non Bernadette, che abbandona i piatti vuoti sul bancone, arraffa la staffetta dei nuovi, caldi, e corre ancora un altro giro del proprio quotidiano tran tran a ostacoli.
Chiude un istante le palpebre umide e le asciuga lesta con un dito.
Ma non piange, no, Bernadette.
È solo il fumo sapido della zuppa che le ha annoiato gli occhi.
5
Mise en bouche.
Hors-d’oeuvre.
Potage.
Relevé.
Entrée.
Rot.
Entremets.
Dessert.
Niente di meno per Luigi XVI come menù, quasi tutto in porzione doppia. La sua ben nota, rumorosa ingordigia fa il paio spaiato con la frugalità della consorte.
La regina si limita, al solito, a silenziosi e misurati bocconi, il giusto per blandire l’appetito. Non mangia. Ammira. Annusa. Assaggia. Assapora. Gratifica i suoi più nobili aspetti e con questo l’opera di un artista del gusto come Philippe Lamont-Souvier.
6
Intanto, in attesa dietro la porta del salone da pranzo, Philippe Lamont-Souvier origlia.
Impastati slap di lingua decretano la bontà del foi grass, mentre i cric croc esaltanto la fragranza della Bouchée à la reine. I cucchiai tintinnano fra lunghi, sbrodolati slurp e composti mhhh d’approvazione per il potage. I coltelli affondano in un rip sommesso nella morbidezza del filetto in salsa. Sonori crunch confermano la croccantezza dell’arrosto, pollo, mentre un continuo gnam gnam di ganasce incorona le quaglie agli champignon. Il cucchiaio si tuffa con un plush nella crema di Brie, giacché un dessert senza formaggio è una bella donna alla quale manca un occhio.
Quando un sonoro, lungo broooot sfugge al bon ton di una mano tardiva e conclude il concerto del pasto, Philippe Lamont-Souvier quasi aspetterebbe applausi e richieste di bis. Il silenzio che segue lo appaga egualmente, e Philippe sospira sollevato.
È andato tutto bene. Magnificamente.
È fatta,
pensa.
Gongola.
Philippe Lamont-Souvier.
Assapora il proprio nome.
Il primo chef della Francia.
Stringe la mano in un pugno di esaltata soddisfazione.
Sei in cima, Philippe.
In testa.
7
– Tagliategli la testa, – urla la folla gremita in Place de la Réunion.
Sul patibolo sfila l’ennesimo condannato per il sanguinario appetito dei citoyens.
Il popolo ha sempre fame: al solito di pane, talvolta di giustizia cui, più spesso di quanto dovrebbe, mal si accosta il piacere della vendetta.
Come un vino con troppo tannino su una meraviglia di porcini.
Questo pensa Philippe Lamont-Souvier mentre, il bavero di un cappotto infeltrito ben stretto al collo contro il fresco vento di ottobre, ottobre mille settecento novantatré, attraversa la ressa che ingolfa la piazza. E a quello che ha perso nella Révolution, e di cui conserva giusto un ricordo agrodolce. La sicura protezione di una Corona ormai nella cesta del boia. Clienti di un rango elevato al pari della rendita che gli garantivano. Una posizione di prestigio. Il suo rinomato La trascendence du Goût. E forse anche il piacere di cucinare.
Ma non la vita.
Quella no, per fortuna.
Poteva andargli peggio, a Philippe, come ad altri servi del potere. I suoi reati poi, col senno della Costituente, avrebbero ben potuto essere degni della pena capitale. Connivenza con la nobiltà. Furto di cibo al popolo. E, soprattutto, l’egocentrico volere di trasformare il basilare sostentamento di tutti in elaborata arte destinata a pochi.
Eppure l’ha scampata.
Perdonato, no.
Dimenticato. In favori di altri. Uno in particolare.
Eccolo, anche lui sul patibolo, fiero e acclamato: il boia Charles-Henry Sanson.
È uno chef anche lui, pensa, come me un tempo. Io con i coltelli, e lui alla ghigliottina. Un taglio perfetto per quel piatto perfetto richiesto dai commensali. Solo che il menù, adesso, è sempre lo stesso e terribile: morte. E Terrore.
E mentre una testa cade sotto lo szock! della giustizia, Philippe scrolla la propria per scacciar via quell’idea, pericolosa anche a pensarla, e ciondola verso il lavoro.
Da primo chef ad aiuto cuoco e sguattero. Dalla Trascendence a… questo.
E sopendo con un broncio storto un lamento di rammarico, inforca l’ingresso della Taverne de pauvre voyageur de Madame Vessai.
8
“Cuoco si diventa, rosticciere si nasce.”
Questo aveva scritto Anthelme Brillat-Savarin in quel Physiologie du Goût che Philippe aveva eletto a Bibbia della propria cucina.
Ironico sia spettato proprio a lui contraddire quell’aforisma.
Da quasi tre anni sgobba per pochi franchi sotto la gretta direzione di Madame Vessai, eppure ancora non ha digerito la rivoluzione del gusto a cui ha dovuto piegarsi. Non affetta di fino, ma taglia con tutta l’approssimazione della fretta per le ordinazioni in lame consunte. Non mescola, ma rigira le zuppe nella loro carnevalata d’ingredienti. Sbattere le portate in cocci sbreccati, con la stessa incuria che un tempo riservava agli scarti e all’immondizia, è il modo attuale d’impiattare. E gli pare di commiserare le pietanze, e tutto il loro potenziale, svilito nella mera natura di cibo da consumare.
No, ancora non lo capisce. Eppure si piega con malcelata ritrosia, fra pentolacce e verdure dal colore triste, a subire la cucina piuttosto che esserne artefice. E gli strepiti di Madame Vessai.
– Philippe, tre stufati di manzo, poco, mi raccomando, e patate e pomodoro.
– Due minestre di cavolo, un pasticcio di frattaglie. Ora.
– Zuppe di pane. Quattro. Svelto.
– Philippe!
Tiene duro, Philippe, perché, nonostante tutto, cucinare, seppure in quel barbaro modo, è l’unica cosa che sa fare. Che lo fa sentire vivo e, in ultima analisi, lo tiene in vita.
Quello.
E Bernadette.
9
Gli si accosta quando, giovane moglie innamorata, lo vede lavare e risistemare le stoviglie sporche con la pena di chi pare volere con quel gesto riordinare la propria vita. Lo carezza sul collo e gli sfiora le labbra con un bacio.
– Cos’hai?
– Bernadette, – le prende mani nelle proprie – come si fa vivere così?
– Non conosco altro modo da quando sono nata.
Philippe abbassa lo sguardo, colpevole.
– Scusa.
Lei si sbarazza del proprio fastidio e dell’imbarazzo di lui con una scrollata di spalle.
– Suvvia, – lo consola – non sarà sempre così. Le cose cambieranno. È la Révolution.
– A me ha portato via tutto. – Pausa. Ritrova il sorriso. – Ma mi ha dato te.
– Sei un uomo fortunato, – scherza lei.
– Molto.
Si abbracciano, stretti in un amore così pulito fra quei tegami incrostati d’unto.
– Un giorno, – dice lei – un giorno ce ne andremo via da tutto questo.
– Te lo prometto.
Lei coglie un’esitazione nella sua voce.
– Ma?
– Ma non penso si possa fuggire da ciò che si è.
– E tu sei uno chef. – Sa tutto di lui, Bernadette. Per questo gli si è data in moglie. – Il migliore. La gente cambierà. La Francia cambierà. E ricorderà il tuo nome.
E, come invocato, questo risuona autoritario, seppur nella domanda, alle loro spalle.
– Philippe Lamont-Souvier?
Sulla porta sosta un uomo ben vestito, scortato da due popolani armati di moschetto.
– Philippe Lamont-Souvier? – ripete.
Bernadette trema e Philippe annuisce, muto.
La vita, pensa, è un cameriere che ti presenta sempre il conto. E tu paghi.
– Ci segua, monsieur Souvier, – dice l’uomo. – La Francia la reclama.
10
La cella nella Tour du Temple è fredda e angusta forse quanto un loculo. D’altra parte è lì e ora, sedici ottobre mille settecento novantatré, che si consuma la vigilia del funerale di una donna e, con lei, di un’epoca. La fine dell’ancien régime.
– Sua Maestà.
– Mio caro Philippe. – Con un cenno della mano Maria Antonietta lo invita a lasciar morire un abbozzo d’inchino che non ha più ragione di essere se non nella galanteria. – Non sono più la tua Regina, ma lo stesso richiedo i tuoi servigi.
– A sua disposizione.
– Sai perché sei qui?
– L’ultimo pasto del condannato, immagino.
Maria Antonietta fa un impercettibile cenno di assenso della testa, come se ancora si facesse carico del pesante, precario fardello della corona.
– Una prassi che nella sventura non posso che gradire, anzi. – Fa spallucce e si passa mesta una mano sul ventre smagrito. – L’ultima cena, sì. No, niente blasfemie. Ma questo è quanto, e voglio che sia tu, come un tempo, a preparala.
– Qualche desiderio particolare?
– Giusto il tuo tocco insolito, per ricordo. – Ha il volto sbiancato che pare il crollo di un muro. – Ma ho solo fame, ora, Philippe, – sussurra. – Solo fame.
Philippe non ne dubita: poco è rimasto della donna che poteva concedersi il lusso di trattare i cibi più elaborati con una raffinatezza tale da sfiorare quasi l’offesa verso chi non può. Ha una voracità scolpita nelle guance grinzose che ricorda quella del defunto marito. Lo stesso appetito, ma non così ingordo. Anzi. Solo sano. E giusto. Lo stesso che vede ogni giorno alla Taverne de pauvre voyageur de Madame Vessai. E capisce, così come sa che ha fatto la Regina, quale sia il giusto equilibrio fra gusto e fame.
E anche il popolo, pensa, quando avrà appagato il suo appetito con la Rivoluzione, e si riterrà a ragione fin troppo satollo, forse (forse!) potrà scoprire come tenere in pari i piatti di questa terribile bilancia che è la vita.
– Mangerà, sua Maestà – le dice di ritorno dai suoi pensieri. – Gusterà e mangerà, le prometto, come mai ha fatto. – Poi aggiunge – Tutti, un giorno, lo faranno.
11
Tiepido l’autunno parigino, ottobre mille settecento novantacinque.
Sotto un sole che bacia le pareti e i tetti delle basse case borghesi, la Francia di fine secolo sì illumina e ribolle piano, simile al mosto giovane nei tini.
Una brezza lieve spazza le strade dalle prime foglie morte e da qualsiasi altra cosa passata, estate o Terrore che sia. Reca con sé, invece, un profumo nuovo, ricco e buono, di roba da mangiare. E assaporare.
La Rivoluzione è conclusa, ma non quella del gusto.
Quella s’inaugura ora, al pari dell’omonimo La Révolution du Goût.
Fra fornelli e pentole, entro l’aperta accoglienza del proprio ristorante, lo chef Philippe Lamont-Souvier, cucina.
Ancora una volta, cucina.
Per tutti francesi, cucina. Un gusto genuino e raffinato, eppure alla portata di ogni tasca e borghese fame parigina.
E osserva Bernadette che riceve all’ingresso i nuovi clienti, e li accompagna nella gremita convivialità della sala con una grazia priva dell’evidente impaccio del rigoglioso grembo e seno in odore di maternità. Con un sorriso pone al centro della tovaglia, non appena i commensali hanno le gambe sotto il tavolo, una cesta colma di fette di pane con ancora il caldo aroma del forno sulla crosta bruna.
È solo l’inizio, Philippe, si acquieta l’entusiasmo. Ma penso che sarà un buon domani in cui vivere tutti.
Annuisce fra sé e sé.
Sì, una nuova Belle Èpoque.
Sorride al pensiero del menù.
Bon appetit.