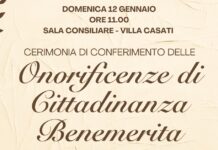“Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera”
(S. Quasimodo)
Guardandoti, ritrovo immutata sul tuo volto la maschera di sempre, rigida e imperscrutabile come quelle che venivano usate nel teatro antico. La tua espressione, scolpita nel gesso delle buone maniere, ha sempre fatto di te un ottimo teatrante, su questo non ci sono dubbi.
Agli occhi di tutti eri il capo famiglia perfetto, il marito irreprensibile, il padre amorevole, l’uomo dai sani principi, il cristiano devoto, l’avvocato incorruttibile, l’intrattenitore dalla barzelletta sempre pronta. Perfetto sotto tutti i punti di vista. Diverso da me che, dentro e fuori casa, alzavo la voce per un nonnulla, facevo a botte con i maschi, prendevo brutti voti a scuola, e non sapevo il rispetto per i genitori. Te ne do atto, nell’ars oratoria, come la chiamavi tu, non avevi rivali. Riuscivi a forare la mente delle persone con la sola forza del verbo, appoggiando la voce sugli accenti giusti. Io no, sapevo solo urlare. Oppure stare zitta, raggomitolata dentro un mondo tutto mio in cui le parole non avevano peso. Un mondo in cui sarebbe bastato uno sguardo per sondare la profondità di un disagio. Un mondo in cui io riuscivo perfino a immaginare che i malesseri potessero scoppiare come una bolla di sapone. Più mi rintanavo e più invece affondavo. Più cercavo l’ombra e più diventavo fantasma a me stessa. Nelle tue mani la mia paura diventava un’arma. Per sentirmi libera ho dovuto fare i conti con la realtà, capire che, a differenza di quello che andavi sostenendo tutte le volte in cui ti capitava di perdere una causa, il giudice non si sarebbe lasciato gettare fumo negli occhi tanto facilmente. Si è comportato da uomo di scienza e coscienza ed è andato oltre i ruoli e le apparenze. Ha creduto ad altri uomini di scienza, i dottori, che per primi mi hanno aiutata ad alzare il velo dell’ipocrisia. L’ultima volta che sono ricorsa alle loro cure, infatti, non hanno permesso che mamma ti giustificasse. Sempre pronta a difendere te e la sua stessa tranquillità, lei aveva il brutto vizio di parlare anche quando non le veniva rivolta alcuna domanda. Raccontava della mia distrazione, delle cadute giù dalle scale, della bicicletta che sbadatamente facevo rovinare a terra. Ti scusava come fanno i deboli, a occhi bassi e senza lacrime. Ripeteva sempre la stessa litania mandata a memoria senza fede e senza cuore.
Lo ammetto, non deve essere stato facile per nessuno alzare un polverone contro di te. Nemmeno il parroco aveva saputo prendere una posizione quando, protetta dalla grata del confessionale, in un bisbiglio, avevo trovato la forza di denunciare le tue colpe e la mia disperazione. Ero alla mia prima confessione, quella che avrebbe dovuto portarmi alla prima comunione, ma, nonostante avessi ottenuto la piena assoluzione, era stata anche l’ultima.
“Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine patris et filii et spiritus sanctus sancti”, aveva detto don Pierino.
In nomine patris, con questa formula lui mi aveva rispedita, più indifesa che mai, a te che mi aspettavi fuori, perfettamente a tuo agio alla luce del sole. Eppure avrei dovuto saperlo, poche ore prima mi avevi avvertita, non osare aprire bocca, avevi bisbigliato nel mio orecchio, tanto nessuno ti crederà. Nella penombra del confessionale, convinta di essere al sicuro, avevo ugualmente trovato la forza per disubbidirti. Da giorni cercavo le parole giuste, ci provavo e ci riprovavo, mescolavo i sentimenti alle preghiere, scomodavo i santi, invocavo il mio angelo custode senza mai ottenere risposta, eppure alla fine avevo vuotato il sacco.
Ero stata rimandata indietro, come se avessi parlato di una birichinata qualsiasi. Ancora stordita dall’odore dell’incenso, dei fiori, della cera sciolta e della vergogna, mi ero chiesta da cosa fossi stata assolta, ma più mi ponevo domande e più mi sentivo confusa. Eri un avvocato. Più influente che stimato.
Ora però le cose sono cambiate. Le parti si sono invertite. Io ho puntato il dito e sono diventata l’accusa. Tu l’accusato. Non sono don Pierino, non ho nessuna intenzione di assolverti purificando la tua anima con la leggerezza di due dita lanciate in aria a tracciare una croce. Non l’ho fatto anni fa in tribunale, e non lo farò nemmeno adesso. Non ha importanza che tu sia qui, in questo letto d’ospedale, con i piedi ormai incamminati sulla via dell’ultimo giudizio. Mi fa un certo effetto rivederti dopo diciassette anni, questo sì.
Tanti ne sono passati dal giorno in cui, spinta dal bisogno di trovare un luogo tutto mio in cui tu non avresti mai potuto intrufolarti, sono sparita dalla circolazione. Per impedirti di rompere i sigilli della mia pace, rossa e fragile come la ceralacca, potevo solo mettermi in viaggio evitando accuratamente le strade che tu avevi scelto e spianato per me a suon di botte. Sapendo quanto tu odiassi la montagna, ho camminato in quella direzione. Non è stato difficile. Senza rendertene conto, mi avevi insegnato a vivere in salita, a posare passi brevi e pesanti, a trattenere l’aria nei polmoni, a cadere e a rialzarmi senza far caso alle ferite, a tenere lo sguardo puntato a terra per essere salda come una cerva che si muove tra un salto di roccia e l’altro. Avevo letto da qualche parte che, secondo Dante, del paradiso non erano rimasti altro che i fiori, le stelle e i bambini, per questo mi ero trasferita in un casale isolato, a due passi dal cielo.
Nei primi tempi non riuscivo a fidarmi di nessuno, vivevo con tutti i sensi in allerta, pronta a scansare pericoli e crepacci, rocce ruvide e intrigo di sottobosco. Eppure, essendo convinta che ci fosse un porto per ogni destino, continuavo a cercare una traccia. Avevo scelto la solidità della roccia per costruirvi il mio nido e la quiete della montagna per erigere il mio eremo, perché volevo sentirmi come un’aquila reale che, quando apre le sue grandi ali, traccia ampie figure di libertà nell’aria.
Riesci a immaginare come sia andata a finire, papà? Per anni non sono riuscita a lanciare sguardi giù, a fondo valle, né a puntare gli occhi nell’azzurro del cielo. Ho semplicemente vissuto la tenacia della terra, cercando e trovando conferme del fatto che i veri lupi non si nascondono nella ruvida asperità della roccia, ma nella falsità che morde e sbrana l’anima, fino a trasformare il cuore di un uomo in un pugno di granito. In montagna, nella mia bella montagna, ci sono tappeti di bosco e infinite sfumature di verde, prati da sfalcio e intrighi di luce. Poco più su c’è il grigio del sasso nudo su cui, dall’alba al tramonto, gioca e rimbalza il sole. Nei castagneti i frutti maturano dentro agli astucci dei ricci, nessuno li forza a cadere prima del tempo.
A me è successa esattamente la stessa cosa. A poco a poco la mia mente, mai del tutto sgombra dai pensieri tristi, ha iniziato a sconfinare, finendo per rifiorire in pensieri di leggerezza. In quel tacere di monti sono perfino riuscita a udire il canto timido del mio cuore. Mi è costata una enorme fatica emergere da quel mondo incantato per venire qui oggi. Ma dovevo farlo. Sentivo che per chiudere definitivamente col passato avrei dovuto, per forza di cose, darti un’altra possibilità.
Nonostante la vecchiaia, tu sei però rimasto quello di sempre. Esprimono molto più delle parole gli occhi, e i tuoi, in questo preciso momento, mi avvertono che non sono la benvenuta. E come potrebbe essere altrimenti? Non mi hai convocata, non mi parli, non cerchi il mio perdono. Ti limiti a fissarmi. Usi lo sguardo come se fosse una spada, non è così papà? So leggerti dentro, per questo non mi è difficile comprendere che, indipendentemente dall’esito della sentenza, credi di avere ancora ragione. Mi hai condannata tanto tempo fa, dal tuo punto di vista io sono l’aguzzina e tu la vittima. La mia querela ti ha portato via fama e prestigio, corte e maniero. Non è più tempo di falsità e messinscena, di accuse e di recriminazioni, sappi però che io ho perso molto più di te. Pur non sentendomi in colpa e non aspettandomi nulla dalla vita, non sono mai riuscita a sentirmi del tutto libera. Non fraintendere, la montagna, colla sua gente, mi ha accolta e difesa. Pian piano ho imparato a rispettarmi. A rispecchiarmi nelle ferite della roccia. Ferite che, anno dopo anno, diventano sempre più profonde. A provocarle sono uomini senza scrupoli che disboscano e bruciano e zittiscono e spopolano e spaccano e mettono a nudo il sasso e distruggono tutto quello che capita loro a tiro. Uomini come te, papà. Uomini che ti frugano nelle viscere per poi disconoscerti ed esporti alla pubblica gogna. Uomini che, alla prima occasione, ti vendono al miglior offerente. Credo sia per questo che più i tuoi occhi odiano, più i miei si vanno riempiendo di montagna e di luce. Come vedi, la distanza che da sempre ci divide, si ripropone di nuovo a ruoli invertiti. Tu, disteso tra le lenzuola candide come un manto di neve che ricopre la tua debolezza e la malattia che ti consuma, sei più orizzontale, piatto e gelido di una pianura aggredita dall’inverno. Io ti osservo, ferma ai piedi del letto, con la fragile solidità di un carpino aggrappato a un salto di roccia. Ho il cuore ancora inzuppato nell’aria della primavera, per questo e non per orgoglio non piego il capo. Sono come un fiore che ha appena lasciato il suo amato prato. Tu sei tutto intento a non lasciar trapelare l’imminente fine, io invece sono ancora immersa in una fiaba senza tempo. Non ti penso più come il centro dell’universo, il campanile che sale e sparge da una valle all’altra la sua benedizione, le sue verità. Da tanto ho imparato a non girare attorno al tuo universo, ma avevo bisogno di questo istante per capirlo fino in fondo. Per scrostarmi dalla testa e dal cuore le ultime tracce di quei giorni pesanti che sono stati la mia infanzia al tuo fianco. Giorni in cui l’uomo nero aveva fattezze fin troppo note. Giorni in cui gli incubi della notte non conoscevano lo sbocciare rassicurante del sole. Giorni in cui le punizioni diventavano una faccenda di ripostigli bui, luoghi privi di qualsiasi ricircolo d’aria. Da quando non devo più preoccuparmi di trovare l’ossigeno e la luce necessaria a restare in vita, sono rinata. Ho iniziato a credere in me stessa. Sì, oggi sento che la mia forza è reale. A conferma che le promesse, le minacce e le lusinghe con cui fino all’ultimo hai tentato di chiudermi la bocca durante il processo, non erano che vento di zizzania. Ti vedo sai? Nonostante tu sia stremato e ferito sei peggio di una bestia, non lasci la presa. Non potendo o forse non riuscendo a parlare, usi gli occhi per braccarmi. Mi stringi in un assedio di ghiaccio, il colore delle tue iridi è quello degli iceberg. Strano, non lo avevo mai notato prima, forse perché fino a poco tempo fa non alzavo lo sguardo. Ora non mi fai più paura, continua pure a tenermi il dito puntato contro, per me non ha più importanza se gli altri non possano o non vogliano riconoscere il male che mi hai fatto. Bastano i miei ricordi a fare da confine. A ripararmi dai colpi delle tue mani, sempre gonfie di botte, sempre pronte a calare e a lacerare le mie carni. Tra noi c’è un solco enorme che gli anni hanno approfondito. Se ho deciso di scavalcarlo, è solo per restituirti il passato.
Lo faccio a modo mio, facendoti vedere la donna che sono diventata. Non si tratta di una sfida, solo una specie di contraddittorio. I ricordi sono specchi… riesci a vedere le impronte che hai lasciato sulla loro superficie, papà? Sono pesanti come pietre, eppure sono riuscita a stanarle e a riportarle a te… girano attorno al tuo letto, tutte assieme fanno più rumore di uno sciame di api impazzite. Puoi starne certo, presto si poseranno sulla tua pelle per restituirti i morsi del tuo stesso veleno.
“L’ora di visita è terminata. Signorina, deve uscire.”
Ecco. L’infermiera, senza nemmeno rendersene conto, ha messo fine ai nostri tempi irripetibili. Ancora una volta è toccato ad altri definire i confini. L’ospedale, proprio come un tribunale, è fatto di ordine e di rigore. Di regole e di orari. Qui ognuno ha un ruolo e un posto predefinito. Durante questa ora, nessuno di noi due ha mosso un muscolo. Ti lascio che sei ancora vestito della tua solita, massiccia superbia. Io che invece indosso i miei nuovi orizzonti, posso tornare, finalmente libera e leggera, al mio piccolo casolare. Dista mezz’ora di cammino da un minuscolo paese, appena una manciata di case, in cui tutto mi parla di famiglia. Più terra e verde e roccia che casa e muri e strade. Lassù l’aria profuma di fienagione e i limpidi cieli conoscono il volo maestoso delle aquile. Per me non si tratta di un semplice rifugio. Non più. In montagna mi sento davvero bene. Respiro. Vivo. E come un fiore di prato mi apro al soffio del vento che rotola sulle rocce, le scala intessendomi dentro un ricamo di terra e d’azzurro. E sai perché, papà? Perché anche una cerva ferita, finché il suo cuore batte, trattiene tra gli zoccoli orizzonti di luna che nessun cacciatore riuscirà mai a impagliare.